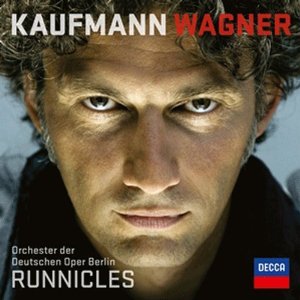
In questo recital Jonas Kaufmann si propone in sei ruoli
wagneriani, dei quali soltanto la metà già affrontati sul
palcoscenico: eppure, almeno in disco, il tenore bavarese non
appare meno convincente nei panni di Siegfried o Tannhäuser che
come Lohengrin o Stolzing. Mi ha colpito in particolare la scena
della foresta dalla seconda giornata della Tetralogia, in cui
sbalza un eroe-fanciullo di tinta baritenorile, introverso ma
facile agli slanci, arricchito da moltissime sfumature
espressive: dalla tenerezza verso la madre mai conosciuta, al
brivido di « Sterben die Menschenmütter an ihren Söhnen alle
dahin? », al sorriso con cui rinuncia a imitare con la canna il
canto dell'uccello; una prova capace di vincere molti confronti
nella discografia. L'orchestra berlinese ha ovviamente qui modo
di mettersi in luce, così come nella Romerzählung da Tannhäuser,
altra prova davvero convincente, ricca di annotazioni e sempre
cantata, anche nei momenti più concitati; anche per il
Minnesänger Kaufmann sembra possedere la «grana» e la capacità
di comunicarne i tormenti.
Il tenore afferma di aver
scelto «Ein Schwert verhiess mir der Vater » dalla Valchiria
attratto in primo luogo dalla sfida dei Wälse-Rufe: il Sol
bemolle e il Sol naturale, tenuti a lungo, sono in effetti
elettrizzanti, e ancora più luminoso il Sol su «Herz » sette
battute dopo; anche se una voce di pasta un poco più chiara è
avvantaggiata nel riempire di luce e colori l'evocazione di
Sieglinde, questo Siegmund incide nella memoria per il timbro
scuro, perfetto per i passaggi più virili e ombrosi. Il suo «Am
stillen Herd» dai Maestri Cantori suona invece cavalleresco,
concluso da un efficace trillo sul Mi naturale; ma la curiosità
del recital è «In fernem Land », proposto nella Urfassung che
comprende una seconda strofa. L'attacco in mezzavoce è molto
suggestivo; e ricco di magia è tutto il racconto, innervato da
un ardore a stento trattenuto. Morbida la mezzavoce sul Mi di
«Taube », squillanti tutti i La naturali, anche se su «Ritter»
Kaufmann ricorre al classico trucco di pronunciare una « a» per
non chiudere subito la gola.
Nell'intervista contenuta
nel booklet, Kaufmann evoca per la versione originale del brano
il precedente della registrazione di Franz Völker (1936): due
vocalità agli antipodi. Nel caso del grande predecessore avvince
subito la voce proiettata interamente sul fiato, l'uniformità
tra i registri, e una maggiore naturale plasticità della
dizione; dal suo Lohengrin promana un più evidente carattere
aristocratico e sovrumano, anche se forse il personaggio di
Kaufmann risulta più sfaccettato. Ma è soprattutto nella
Preghiera di Rienzi che Völker (1930) vince per naturale
nobiltà: le sfumature dinamiche sono ridotte, ma grazie
all'eloquenza intrinseca il personaggio emerge con forza,
assorto ed eroico, e il finale suona davvero poetico. Kaufmann
deve «faticare» molto di più per incidere espressivamente, e
inoltre il suo attacco in mezzavoce gli attirerà le critiche di
chi lo accusa di avere un'emissione gutturale. Ma appaiono
incontrovertibili anche le qualità: il legato mantenuto anche
sulle note ribattute, la credibilità del canto fiorito,
l'elettrizzante «Schenk uns den Abglanz deiner Macht / die sich
in Ewigkeit erstreckt! ». Se scendiamo a confronti più
realistici, ad esempio con un altro tenore wagneriano di
successo dei nostri giorni come Klaus Florian Vogt, che ha
inciso la stessa aria in un recentissimo recital Sony,
semplicemente non c'è match: la voce è molto più chiara ed
esile, pochissimi i colori a disposizione, il registro acuto più
scoperto, il fraseggio scolastico e povero di dettagli.
A
completare il palinsesto vengono inusualmente chiamati i
Wesendonck-Lieder. Anche se nel titolo originale la raccolta
viene attribuita esplicitamente a una voce femminile, Kaufmann
non è certo il primo tenore ad affrontarli (in passato ad
esempio li ha incisi René Kollo), e soprattutto all'epoca di
Wagner nessuno avrebbe sottilizzato. Inoltre questa sorta di
lavoro a quattro mani tra Richard e Mathilde è basato su una
sublimazione simbiotica del loro rapporto che include
l'orizzonte di un annullamento delle differenze tra i sessi.
Personalmente trovo soltanto «Schmerzen» inadatto a una voce
maschile, risultando inevitabilmente un po' esteriore (e qui
addirittura appena truce); stanno ovviamente benissimo addosso a
un tenore wagneriano, invece, le tinte tristaniane di « Im
Treibhaus », studio preparatorio per il Preludio del terzo atto.
Per questo Lied desolato l'atteggiamento interiorizzato di
Kaufmann è perfetto, considerazione estensibile anche a «Träume
», proposto in maniera molto intima, accordata alla natura
ipnotica del brano: molto affascinante il morbidissimo attacco,
e lodevole l'attenzione alle prescrizioni dinamiche ed
espressive. Che vengono invece stranamente (per le consuetudini
del tenore) trascurate nell'iniziale «Der Engel »: vedi le
ripetute messe di voce (ad esempio su «Erlösung») e
l'indicazione «con entusiasmo» a «Führt er ferne». Probabilmente
si tratta di una scelta consapevole, dovuta alla volontà di non
turbare un'espressione trasognata indubbiamente in sintonia col
clima trasfigurato del brano.
|