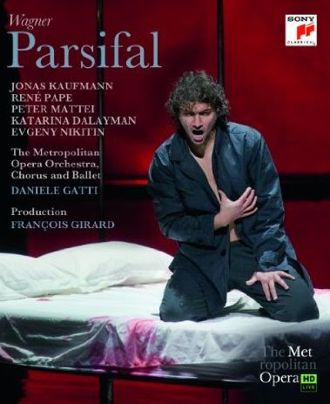
In un'eventuale categoria delle opere più difficili sia per chi
le deve mettere in scena sia per chi deve vederla in teatro,
questa ho idea starebbe tra le prime tre. Sovraccarico com'è il
testo di simboli di natura pseudofilosofica (e si tratta pur
sempre di simboli riferiti a cosucce tipo cristianesimo,
consorterie religioso-militari, inconscio, crescita individuale,
la Mamma, la Donna, il Sesso, persino uno zinzino di
metempsicosi), resta comunque aperta la questione del valore da
attribuir loro - tanto? poco? niente? - e soprattutto del come
trattarli (spiegarli? far finta di niente con luci astratte
dietro al solito paravento del "tanto c'è la musica", che in
effetti e meno male che c'è? sostituirli con altri meno
imbarazzanti e, diciamocelo, un tantino più interessanti?):
avendo anche in mente che, ci credesse davvero o no, Wagner
dichiarò a chiare lettere di considerarli materiale
squisitamente teatrale nonostante l'evidenza del loro
configurarsi piuttosto come autobiografia psicanalitica.
La storia scenica di Parsifal, in definitiva, si distende sul
ventaglio di risposte a questi pochi quesiti: e la stragrande
maggioranza hanno scelto di lasciar tutto com'è, squadernare i
simboli in quanto elementi narrativi, e lasciar decidere il loro
significato a chi ascolta. E tuttavia, oggi è proprio difficile
stare immobili e compresi di sacro furore speculativo davanti
alla solita coppa-insalatiera che s'illumina di rosa confetto,
al cignone morto, alla colombella salvatrice, agli scudieri che
fanno i dispetti a una barbona, a una vamp che seduce un
ragazzino (di solito un cinquantenne di un quintale e mezzo)
dicendogli dammelo dammelo che così mamma è contenta, d'un
cattivone che piomba tra loro con lancia in resta come Sandokan
ma in nome d'un Principio Superiore. Non si può più. Nemmeno al
Metropolitan (e forse forse, neppure alla Scala). Allora: o si
cambia tutto proponendo una storia diversa come a Bayreuth hanno
fatto Schlingensief ed Herheim; oppure si gattopardeggia, ovvero
si lascia tutto com'è ma si fa finta si sia cambiato tutto
perché presentato in modo diverso, più accettabile perché
visivamente più attinente a sensibilità, abitudini, senso
visivo, odierni. Che per l'appunto è quanto fa Francois Girard,
regista canadese noto finora soprattutto per il suo film II
violino rosso con le musiche di Corigliano suonate da Joshua
Bell.
Via le cose più imbarazzanti come la coppona e in
generale la Sacra Agape, ma si tiene il sangue. Una caterva di
sangue, a rappresentare una Colpa Collettiva. Che quale sia,
importa poco. C'è stata, c'è ancora e riguarda tutti: un sipario
riflettente informa fin dall'inizio che in scena ci siamo anche
noi. Viene in mente Nietzsche, se guardi a lungo nell'abisso,
l'abisso guarda dentro di te. Colpa che ha isterilito la terra,
resa un mondo post-apocalittico simile a certi paesaggi africani
arsi e spaccati da una siccità non causata dal meteo bensì dalla
mancanza della reciproca comunione uomini-donne: gli uomini
(riuniti in circolo, forse allusione alla "ruota della
sofferenza" cara al buddismo) pregano nella speranza che
quest'aridità cessi, ma riescono a farlo con una mano sola,
l'altra essendo loro impedita dall'assenza dell'altra metà del
cielo. Cielo, coi suoi pianeti rotanti che incombono e
s'eclissano entro luci sempre cangianti ma sempre cupe, che
scorgiamo nelle spettacolari, modernissime proiezioni di Peter
Flaherty. L'espiazione sarà possibile solo allorché lancia e
coppa — maschile e femminile — saranno nuovamente riuniti: onde
viaggio all'interno della colpa ovvero dentro la spaccatura
della terra (il second'atto, su un letto da cui cola sangue e
circondato sempre da Fanciulle Fiore impegnate in coreografie
che alludono di continuo alla croce) per riuscire a comporre la
fenditura che ha diviso in due la terra, su cui è scorso il
sangue che alla fine tornerà acqua e, in quella ritrovata "terra
di mezzo", uomini e donne si ricongiungono in una reciproca
comprensione che rappresenta quel supremo atto d'amore unico
possibile redentore d'ogni colpa.
Nulla di nuovo, insomma
(tanto per dire, la metafora uomo-donna l'aveva mostrata anche
Denis Krief alla Fenice, con analoga parsimonia simbologica e
assai maggiore parsimonia di mezzi), e in fin dei conti
semplice, quantunque non semplicistico. Riuscire però a tenere
assieme questo coacervo di bignamino scolastico di filosofia e
mercatino di tutt'un po' - dal buddismo in salsa
schopenhaueriana al catechismo spruzzato d'antisemitismo,
all'ecologismo in salsa spicciola, al puritanesimo che sempre
assilla chi troppo mostra di averne in uggia - accettandone i
muri narrativi portanti senza stravolgerli perché riassorbiti
nel racconto: questo, che significa poi teatro pragmaticamente
inteso perché tiene conto del pubblico (e perché, forse Wagner
no? ma si faccia il piacere!), è cosa tipicamente americana.
Evviva gli americani. Giacché vediamo un Parsifal messo in scena
tenendo conto di quanto oggi la nostra sia una civiltà
soprattutto d'immagini, e di quanto conti - a teatro -
raccontare. Dunque recitazione: modernissima nell'impiego d'ogni
possibile mezzo fisico mimico e in genere posturale, ma
soprattutto marcatamente comunicativa, in virtù anche delle
riprese della Sweete, superlative non solo di per sé ma per la
natura squisitamente televisiva, cioè a dire narrativa, in cui
sono organizzate, da vero e proprio sceneggiato di gran classe.
Cosa riesce a fare ad esempio Peter Mattei nel comporre una vera
e propria sinfonia del dolore (esibito fino all'impudicizia,
senza il minimo desiderio d'interiorizzarlo dandogli un
significato trascendente, ma con addirittura inediti tocchi
d'infantile rivalsa: sì, ci sono cascato, vi ho rovinati tutti,
ma soffro così tanto che di voi m'importa niente), getta su
Amfortas luce completamente nuova ma soprattutto d'impatto
teatrale portentoso. Se si aggiunge un canto che sormonta con
estrema disinvoltura ogni difficoltà di tessitura, nel contempo
scavando ogni parola con l'impiego d'una tavolozza cromatica
sterminata: ecco che con questo video la storia interpretativa
del personaggio gira un tornante epocale e, di fatto, ricomincia
da qui.
Considerazioni analoghe per Jonas Kaufmann, il
Parsifal dal quale oggi - forse persino più di Lohengrin - si
giudicheranno tutti gli altri. Personaggio più difficile, il
suo: quasi tutto il prim'atto e larghissima parte del terzo
vanno costruiti col gesto e con la mimica non solo facciale ma
di tutto il corpo. Come riesca a esprimere una sofferenza non
meno acuta di quella di Amfortas ma -questa sì, non si può fare
altro - tutta interiore, cupa, ogni tassello di comprensione un
uncino che affonda nella carne: un capolavoro cui scavo della
parola musicale, gesto, atteggiamento, e sopra ogni altra cosa
sguardo, concorrono in pari misura.
Di fronte a due
siffatti monumenti, difficile non sfigurare: dire che nessuno
scalpita più di tanto, è dire abbastanza. Pape, con la sua voce
ampia, splendida, esaltata da un legato superbo, cesella pure
lui ogni parola e il suo Gurnemanz, condotto e tenuto al grado
minimo di pontificante pedagogo, non solo non annoia ma
interessa. Klingsor, invece, non annoia quasi mai però quasi
sempre non si capisce che personaggio sia: qui Evgeny Nikitin
(tatuaggi nazisti o no, del politically correct francamente non
se ne può più) gli dà fisionomia di potentissimo rilievo.
Katarina Dalayman ha il problema di trovarsi in gola un gran
brutto timbro: voce però ampia e sonora, emessa piuttosto bene,
che onora tutte le richieste vocali d'una parte difficilissima,
ma tanto vocalmente quanto scenicamente pattina un po' troppo
alla superficie del personaggio (specie dovendo fare i conti coi
due mostri che le stanno accanto), e se riesce a dargli comunque
un'attendibile fisionomia, è soprattutto merito della direzione.
Giacché resta fermo che perno decisivo di questa sensazionale
riuscita è Daniele Gatti. Nervature ampie, possenti ma allo
stesso tempo agili, dove si scarica la forza d'un edificio
musicale in ogni giuntura pienamente leggibile. Cura estrema
nell'indagare la microstruttura timbrica e armonica seguendo
però sempre la bussola del teatro, ovvero evidenziando di
ciascuna il suo inserirsi entro una macrostruttura tenuta in
tensione narrativa costante. Quella in cui serrate urgenze e
maestose dilatazioni melodiche sono sistole e diastole d'un
flusso teatrale sempre teso e "in avanti", affatto privo sia
d'ogni cincischio calligrafico riferibile sia ai tipici schianti
tellurici del Wagner tanto effettistico quanto vuoto di reale
contenuto drammatico, sia alla polenta meditabonda del vecchio
teatro filosofico tutto immobilismo pensoso avvolto da luci
metafisiche: la tensione, insomma, di chi il teatro musicale lo
realizza certo con la musica, ma anche col teatro. E dunque, un
grande Wagner. Di più. Il Wagner migliore che si sia ascoltato
da moltissimo tempo, oltre che, naturalmente, il Parsifal più
compiuto ed emozionante dell'intero catalogo discografico: e
l'aggettivo "emozionante", riferito a un'opera come questa, a me
pare costituisca il discrimine decisivo.
|